
29 Ott LA NUOVA PARTECIPAZIONE POLITICA. LO SPOSTAMENTO DEL BARICENTRO DELLQ PARTECIPAZIONE DAI PARTITI ALLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZATA
La partecipazione politica può definirsi come un insieme di azioni e di comportamenti che mirano a influenzare in maniera più o meno diretta e più o meno legale le decisioni.
Chi partecipa, poi, ha un interesse personale. Senza interesse non c’è partecipazione.
Il paradosso di tutte le pratiche partecipative, peraltro, consiste nel fatto che in teoria esse si rivolgono indistintamente a tutti i cittadini, ma in pratica riescono a coinvolgerne solo una piccola minoranza.
Si afferma comunemente, ma in modo semplicistico aggiungo, che l’allontanamento dei cittadini dalla partecipazione nei partiti sia causato da delusione e sfiducia nel loro operato.
I reali motivi dell’innegabile declino della partecipazione, però, sono conseguenti, anzitutto, al venir meno delle basi sociali della forza e coesione dei partiti.
Il deficit di rappresentanza è il fenomeno su cui tutti concordano; i partiti non riescono più ad essere espressione delle domande sociali, non hanno più il monopolio della rappresentanza.
Il ritorno di fatto del potere monocratico costituisce un altro motivo del declino della partecipazione, come osserva acutamente Mauro Calise nel” La Democrazia del Leader”.
In Italia, ma anche in Europa, siamo di fronte al tramonto dell’ultimo grande corpo collettivo, il partito.
Per spersonalizzare il potere del sovrano ci sono voluti secoli, ora siamo al processo inverso.
Nelle democrazie contemporanee, innanzi al declino della partecipazione partitica, sono emerse nuove forme di partecipazione.
La partecipazione della società civile si realizza oggi attraverso la rete, il web, mediante: piattaforme di civic engagement, consultazioni online, forum, piattaforme digitali, account social di politici e amministrazioni pubbliche.
Tutti questi strumenti rappresentano le nuove forme della partecipazione, ma senza forme culturali nuove non potranno realmente rimuovere i limiti alla partecipazione che la società stessa ha creato.
Così come non saranno in grado di sostituire la partecipazione nei partiti essendo forme di partecipazione limitate nel tempo o limitate a un singolo obiettivo.
Per altro verso sono forme di partecipazione che rischiano di naufragare essenzialmente per due motivi.
Il primo è quello della sfiducia che limiterebbe l’utilizzo di questi strumenti se attraverso tali nuove forme di partecipazione non si raggiungesse il risultato auspicato.
Il secondo motivo è che manca una regolamentazione dell’intervento finale di tali forme di partecipazione tesa ad influenzare concretamente ed in modo formale il decisore pubblico.
La partecipazione politica, infatti, è inevitabilmente condizionata dalla scarsa fiducia nelle capacità di influenzare il sistema politico.
Non è un caso che i temi dell’informazione e della partecipazione costituiscono oggi uno degli argomenti centrali del dibattito comunitario e nazionale sulla Governance pubblica.
Un riferimento in tal senso è il Libro Bianco sulla Governance nel quale si osserva: “La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dipendono dall’ampia partecipazione che si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione.
Con una maggiore partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale e nelle istituzioni da cui emanano tali politiche.
In tale ottica le nuove forme di partecipazione per poter essere credibili dovrebbero tendere a costruire contatti formali con i decisori pubblici attraverso una mediazione professionale.
In società complesse e stratificate gli interessi in gioco sono talmente numerosi – e diversi tra loro – che pretendere di affidarne la tutela a una partecipazione non mediata da un soggetto professionale è ingenuo.
Con la democrazia partecipativa si coinvolgono i cittadini nell’assunzione delle decisioni.
Con la rappresentanza professionale degli interessi ci si serve di un mediatore esterno, di un “filtro”, tra cittadini e decisori pubblici.
Un modello partecipativo efficace e rispondente alle esigenze di una comunità complessa, come quella attuale, è costituito, quindi, dalla previsione di una mediazione professionale tra la partecipazione dei cittadini e il decisore pubblico.
In quest’ottica la partecipazione politica potrebbe tornare a crescere perché una mediazione professionale e regolamentata darebbe risultati concreti da un lato; per altro verso contribuirebbe a migliorare la qualità delle decisioni e, soprattutto, ad accelerare i tempi della loro attuazione.
E solo tale tipo di partecipazione sarebbe in grado di sostituire la partecipazione nei partiti.
E, infatti, change.org in tal senso offre lo scenario più interessante tra le nuove forme di partecipazione.
In Italia, però, tale strumento ha dei limiti nella mancanza di previsione normativa di un contatto formale con il decisore pubblico; a differenza dell’America ove è possibile rivolgere petizioni al governo in modo formale.
La via delle forme di partecipazione della società civile è, quindi, ancora in evoluzione.
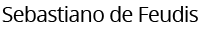
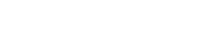
No Comments